Burattini d’erba
Quella cicatrice che scende netta lungo il mio occhio destro, che dal sopracciglio mi solca la pelle scavando un cratere color ebano, dividendomi idealmente il volto in due emisferi simmetrici e sovrapposti, è il ricordo d’un immenso orrore, affondato nella mia anima e che riemerge implacabile tutte le notti, ma, tutte le volte, nel mio quotidiano divenire, mi spalanca le porte delle più note e prestigiose aziende, dei più altisonanti studi professionali.
Come se, per una arcana ragione, tormento assoluto e disperata forza d’animo, si fondessero a costituire un Giano bifronte, volto al passato ed al futuro a un tempo.
La società per cui lavoro si occupa di acquistare gli spazi che occorrono alle grandi aziende per lanciare le campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione. E le grandi aziende, se noi rendiamo setosità e compattezza, d’impatto acquistano pubblicità. Pubblicità, mi occupo di pubblicità.
Al di là e al di sopra di variegate conoscenze di mercato, del mio studio competente e approfondito, di accurata analisi ed affannosa ricerca di canali d’azione, vendo me stesso. E le mie infinite sfaccettature.
L’incipit è però costituito dallo sguardo, il mio, i miei occhi, due fiaccole ardenti in cui il dolore è così profondamente impresso da averli resi, in un innesco di reazione uguale e contraria, una miscela vigorosa e incandescente di pura energia, un avvolgente balsamo, morbido e fluente, di fiducia che si rinnova ogni istante. Mai avrei immaginato che la mia faccia tanto ingiustamente martoriata, tanto sofferente, fosse in grado di sprigionare un potenziale emotivo così impetuoso e sincero, da far si che io acquisissi in un tempo minimo, un innumerevole pacchetto di clienti e con umiltà, tenacia e amore riuscissi a conquistare il cuore della gente. Che amo, così come amo la mia vita, perdutamente.
Ma, nell’oscurità, mi sembra di risentirle, e nettamente distinguerle, le voci dei miei fratelli, le loro voci accorate, ancor prima che all’unisono riecheggino in un coro di aiuto, soffocato repentino da uno, più crudo, opprimente, di morte. E i loro occhi assieme ai miei sono gli occhi della passione, dell’abbandono, di una cupa tribolazione. Abitano il mio cuore. E tutte le notti mi sveglio, osservo silenziosamente mia moglie, il suo angelico viso di luna, il suo lucente incarnato bianco latte, il suo respiro regolare ed impalpabile, mi sembra di trattenerlo tra le dita, ed i miei adorati figli, avvolti in un sereno, lieve torpore.
E il tumulto del cuore per un istante s’acquieta, ma un amaro senso d’impotenza aleggia perpetuo, in una danza senza suoni né colore alcuno. E’ un profumo dell’assenza, di notti di sogni infranti, di chimere al vento. E brucia. E finché brucia è vita. E nella vita la prospettiva da cui osserviamo il corso delle cose muta continuamente, assieme a noi, in un eterno sconosciuto susseguirsi di fotogrammi d’esistenza.
Quella stessa esistenza che ai miei fratelli è stata rubata per sempre, irrimediabilmente, cui Azrael, l’impietoso angelo di morte, ha baciato gli occhi in un ineluttabile sonno eterno.
E ad ogni alba, carezzando davanti allo specchio la mia lunga cicatrice che, se apparentemente ha smesso di bruciare, è un fuoco divampante, imperituro, scolpito dentro me, il cui dolore si rinnova ad ogni sorgere del sole, me lo ripeto, quasi fosse una dolce nenia incantatrice: “ sono vivo, sono vivo”. Tale filastrocca non mi incanta né mai lo ha fatto.
Mi chiamo Fretesfa, che nella mia lingua significa seme della speranza. La speranza, contrapposta alla disperazione, maledetto status ombroso e tentacolare con cui ho condiviso i miei anni, il mio fiore d’anni. Ne ho trenta, me ne sento addosso sessanta.
Come se avessi vissuto per emozioni, spigoli, battiti, due esistenze in un solo spirito. Nonostante tutte le brutture calpestate lungo il mio cammino, sono stato fortunato.
Quella vita, che dal buco della serratura osservavo incredulo, l’ho bramata, inseguita, raggiunta. Il mio sentiero per la libertà si è fatto palpabile, si è concretizzato in un passaggio per un percorso accanto alla morte.
Ed i miei occhi si inumidiscono di un pianto aspro e soffocato, chè i miei non odano, quando ripercorro col pensiero, nelle mie frequenti veglie travestite da notti, la rotta del mio amaro esodo.
E quegli stessi occhi sembrano indurirsi e le lacrime divenire granelli di cristallo, al ricordo di tanti patimenti. Un’atmosfera surreale, una vita nella vita, il mio viaggio. Anima all’anima, emozione all’emozione.
Quella sera di settembre pioveva tantissimo, quasi piangessero il cielo, la luna, le stelle, con me, lacrime di sangue.
Ho consegnato me stesso, le mie suppliche, al mio Dio, la mia carne ai miei scafisti. La mia pelle, l’odore acre ed impalpabile della plastica con cui mi avevano bruciato per il mio Dio, una marchiatura indelebile sul viso e sul cuore.
Era diventato irrespirabile quell’orribile tanfo per sopportarlo ogni giorno.
Perciò, la fuga.
Accarezzato da un vento notturno tiepido, ondeggiante, complice dei miei passi, impregnato di tutte le mie speranze, del desiderio di riscatto, del mio rivendicare d’essere vivo, d’essere nato libero, della mia smaniosa voglia d’umanità in questo magma di soprusi.
Carico di mille interrogativi, della paura di non arrivare, dei singhiozzi ingoiati uno dopo l’altro.
Davanti a me la mia lunga strada, cominciata a bordo di una jeep che dall’Eritrea, dove sono nato, mi avrebbe condotto al vicino Sudan, poi fino alla Libia e, successivamente, dalla Libia fino all’Italia.
Quella notte piovosa su quell’auto scassata, smisi d’essere carne, diventai ombra. Iniziai ad essere clandestino.
La mia identità, il mio cuore, i miei respiri, sono rimasti ad Asmara, la mia amata terra. Sempre più lontana. In silenzio fino a Khartoum. Da qui scelsi la strada verso la Libia attraverso il deserto, per poi giungere in Europa via mare. Il cammino più rischioso, un deserto che può facilmente tramutare le sue vesti in una sabbia di morte che potrebbe ingoiarti e seppellirti, silente e silenziosa, lasciando dietro di sé pedine senza nome.
Questo siamo, lungo il pericoloso calvario da vita a vita.
Ammassati per giorni e giorni, corpi traballanti di donne, uomini, bambini. L’autista non si fermava neppure il tempo necessario per i bisogni fisiologici.
Se chiudo gli occhi percepisco ancora forte e netto quel lezzo di piscio misto a sudore che ha scandito quei momenti. E un brivido mi corre gelido lungo la schiena.
Il tempo scandiva le sue ore, attimo dopo attimo, lento d’una lentezza vuota e interminabile. Col fiato sul collo, affogato in una costante angoscia d’essere bloccato e rispedito indietro, all’inferno.
Quando le forze sembravano ormai avermi irrimediabilmente abbandonato, finalmente l’arrivo insperato a Tripoli.
Trampolino per il mare, con la speranza di non restarci dentro.
La lunga traversata del canale di Sicilia, una vorticosa giostra, per molti profughi profumata di morte. E’ come scenderci a patti, con la morte, sfidarla, per guadagnare la vita.
Quando il nostro gommone è andato in avaria eravamo già in acque italiane. La guardia costiera di Lampedusa ci ha soccorso e salvati.
La sorte, con i suoi dadi, mi ha favorito. Ancora adesso l’afrore denso del petrolio, appiccicato ai miei vestiti, alla pelle, mi sprofonda fino alle viscere e mi s’incunea, serpeggiante e asfissiante, in petto.
Quasi a voler infuocare un burattino.
Perché questo siamo, burattini d’erba sospinti da una folata leggera, che scalda e raggela, alternando giorno e notte, riso e pianto, nei nostri cuori.
La lunga strada è la via necessaria, l’unica possibile, senza sconti né certezze, per conquistare la libertà di spirito, di pensiero, di respirare, di pregare Dio senza timore che qualcuno ti spari alle spalle, ti cucia per sempre la bocca per un credo.
E fluttuante, persa in questo mare arrossato del sangue dei miei compagni, è riposta la dea speranza, ammantata d’avorio, di raggiungere, saltare su quel treno in corsa verso una nuova vita.
Provarci almeno. Perché i sogni, attraverso la lunga strada, mai muoiono.
Nonostante un cielo scuro come il terrore di non farcela, muto spettatore dell’umano passare, come le labbra dei miei fratelli che sussurrano vita che fugge via, che quella luce che irradia un mondo migliore non riusciranno a vedere.
Anche per loro, per cui il sole non sorgerà più, respiro la mia vita, ogni suo palpito.
Questo è ciò che sono diventato. Mai dimenticherò ciò che sono stato.
La dimensione del silenzio mi accompagna quotidianamente in un altalenante sciabordio soave e leggiadro.
Ma perché il silenzio non esime dalla tempesta?



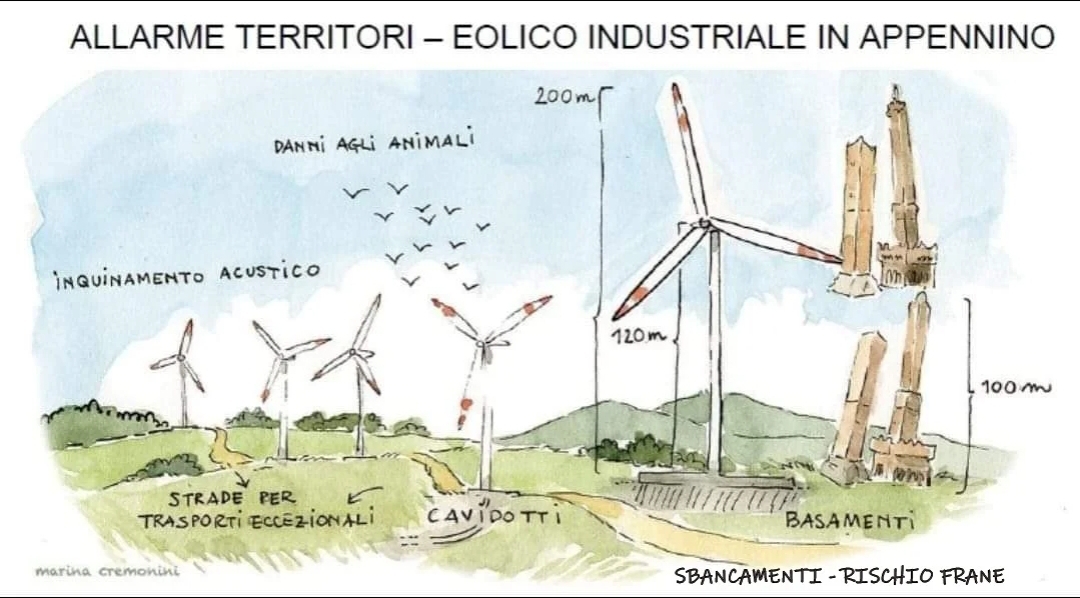
Commenti
Posta un commento